AGI - Con un eufemismo era ipocritamente una «Unione di pace e socialismo», con finalità difensive. Intervenne militarmente due volte non per combattere un nemico esterno ma per soffocare internamente l'aspirazione alla libertà, invadendo l'Ungheria nel 1956 e la Cecoslovacchia nel 1968. Alla storia è passato come Patto di Varsavia, e dalla storia è stato sconfitto. Il 14 maggio 1955 nel palazzo presidenziale della capitale polacca veniva firmata in una solenne cerimonia l'adesione dei Paesi satelliti alla creatura armata voluta dall'Unione Sovietica, esattamente cinque giorni dopo l'ingresso della Germania occidentale nella Nato, avvenuto nel decennale esatto della vittoria dell'Urss sul Terzo Reich.
I trattati di mutua assistenza non bastano più al Cremlino
Quella data sembrava quasi una provocazione, e così il Cremlino aveva reagito all'allargamento dell'Alleanza atlantica soddisfacendo l'esigenza di un più stretto controllo politico e militare su Polonia, Cecoslovacchia, Bulgaria, Romania, Ungheria, Germania Orientale e Albania (che uscirà nel 1961). Gli accordi bilaterali di mutua assistenza erano anch'essi un eufemismo che celava la facoltà di Mosca di intervenire con l'Armata Rossa nell'Europa centro-orientale a sistema comunista a suo solo e insindacabile giudizio. I sovietici intendevano standardizzare la loro dottrina militare e altresì armi, equipaggiamenti e strategia operative nella contrapposizione al blocco occidentale. Non a caso tutti i comandanti supremi interforze e tutti i capi di stato maggiore saranno sempre marescialli e generali sovietici, fino allo scioglimento del 1991. Il Trattato di «amicizia, cooperazione e assistenza reciproca» era imposto dall'alto e solo nominalmente considerava gli Stati aderenti in rapporto paritetico.
Mosca reagisce all'allargamento della Nato e al riarmo tedesco
L'ultimo campanello d'allarme in ordine di tempo era risuonato in Urss nel 1954 con gli accordi di Parigi, che segnavano un ulteriore passo in avanti rispetto al Trattato di alleanza del Nord-Atlantico sottoscritto a Washington dell'aprile 1949 sotto l'egida americana. Il mese dopo, nella Germania territorio di occupazione alleata, nasceva la Repubblica federale tedesca con capitale Bonn, e al di là della Cortina di ferro veniva proclamata la DDR con capitale Pankow, un quartiere di Berlino divisa tra le quattro potenze vincitrici della seconda guerra mondiale. Il fatto che nel mondo libero l'eventuale e discussa riunificazione tedesca non dovesse essere subordinata alla neutralità, aveva portato già il 20 marzo 1952 alla rottura delle trattative con i sovietici. Con la morte di Stalin venne riaperto uno spiraglio dal suo ministro degli esteri Vjačeslav Molotov che nella Conferenza di Berlino del 1952 aveva avanzato la possibilità del consenso sovietico alla riunificazione, ma con il ritiro di tutti gli eserciti di occupazione e l'obbligo di mantenere la Germania disarmata e neutrale, quindi fuori dal Consiglio europeo di difesa. Inaccettabile per americani, inglesi e francesi, che temevano lo svuotamento della ragione stessa che aveva portato alla creazione della Nato, e che avevano fiutato l'obiettivo ultimo della proposta sovietica di entrarvi a sua volta come membro effettivo di un sistema di sicurezza collettiva. Il 23 ottobre 1954 l'annuncio ufficiale dell'ingresso della Germania Ovest nella Nato apriva di fatto al suo riarmo e alla rinascita dell'esercito, erede della Wehrmacht col nome di Bundeswehr.
Perplessità e resistenze sulla Germania dotata di un esercito
I francesi, che ricordavano con timore e rivalsa l'esperienza dell'occupazione tedesca, non erano affatto entusiasti della rimilitarizzazione della Germania e avevano cercato di ostacolarla. Ma ancor più preoccupati si erano mostrati Cecoslovacchia e Polonia, invase e smembrate nel 1939, e la cosa preoccupava anche l'altra Germania, quella comunista; furono infatti proprio questi tre Stati a ipotizzare subito un patto comune di difesa. L'Unione Sovietica, fallito il piano diplomatico di incunearsi nel sistema occidentale per svuotare l'alleanza, assunse la direzione dei Paesi satelliti creando un'alleanza gestita e comandata da Mosca. Il testo del Patto di Varsavia abbonda di dichiarazioni sulla pace, sulla sicurezza, sulla partecipazione, addirittura estesa a «tutti gli Stati europei qualunque sia il loro regime sociale e politico», richiamando i princìpi dell'ONU e «nell'interesse di rafforzare e sviluppare ulteriormente l'amicizia, la cooperazione e l'assistenza reciproca in conformità ai principi del rispetto dell'indipendenza e della sovranità degli Stati, nonché della non interferenza nei loro affari interni».
Le invasioni di Budapest nel 1956 e di Praga nel 1968
Di qua e di là della Cortina di ferro, nel 1955, venivano costituiti due robusti eserciti multinazionali e ben armati che si studiavano, si spiavano, si calibravano con piani ipotetici di difesa e di attacco sullo scenario europeo. Ma non si combatteranno mai, neppure con scaramucce estemporanee. Trentasei anni di guerra fredda scorreranno tra tensioni dirette e indirette, dottrine opposte applicate nei contrasti del Terzo mondo e in altri scenari come in Medio Oriente, Sud-Est asiatico, Cuba. Le uniche due volte che l'Armata Rossa metterà in marcia i suoi possenti carri armati e i suoi soldati con un intervento collettivo del Patto di Varsavia, sarà contro i suoi stessi membri: nell'autunno del 1956 a Budapest per soffocare la rivoluzione antisovietica e nell'agosto 1968 a Praga per stroncare il “socialismo dal volto umano”, (stavolta senza il contributo delle truppe romene) secondo la Dottrina Brežnev che era una sorta di diritto di ingerenza. Anche se l'intervento militare era opera del Patto di Varsavia, in realtà il potere decisionale e la catena di comando erano saldamente in mani sovietiche.
Il crollo del sistema sovietico e lo scioglimento
Il corso della storia spinse a metà deg.li Anni '80 l'Urss verso un'irrealizzabile riforma radicale del sistema comunista che Mikhail Gorbačëv tentò di effettuare con la perestrojka e la glasnost. La periferia dell'impero si sarebbe scrollata di dosso l'opprimente e soffocante tutela sovietica nel 1989. Il crollo del muro di Berlino e lo scioglimento della DDR il 3 ottobre 1990 rappresentarono l'avvio dell'irreversibile disintegrazione del Patto di Varsavia. Sarà preliminarmente sancita da espresse manifestazioni di volontà di Cecoslovacchia, Polonia e Ungheria, seguite da tutti gli altri ex satelliti. Il I luglio 1991 a Praga veniva ufficialmente firmato il protocollo di scioglimento. L'Unione Sovietica si dissolverà prima della fine dell'anno.

 9 mesi fa
123
9 mesi fa
123
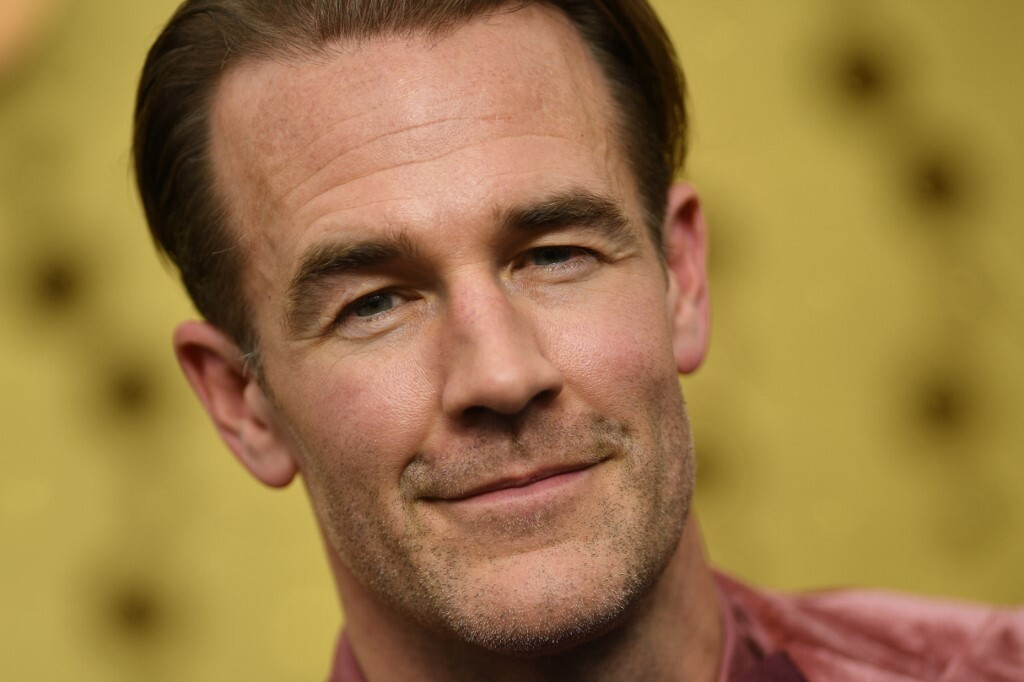





 ·
·
 ·
·
 ·
·
 ·
·
 ·
·
 ·
·
 ·
·
