AGI - Un secolo di espansione urbana e agricola ha cancellato tre quarti della flora naturale delle pendici del Monte Kilimangiaro, in Tanzania. Secondo uno studio pubblicato su PLOS One da Andreas Hemp dell’Università di Bayreuth e colleghi di Giappone, Finlandia e Svizzera, la principale causa di questo declino è il cambiamento nell’uso del suolo provocato dalla crescita demografica e dallo sviluppo economico, e non il cambiamento climatico, come spesso si sostiene.
Il Kilimangiaro, il più alto rilievo dell’Africa e un’icona ecologica mondiale, ospita una straordinaria varietà di ecosistemi che forniscono legname, acqua e risorse alimentari a milioni di persone. Tuttavia, tra il 1911 e il 2022, le sue pendici inferiori hanno subito una perdita del 75% delle specie vegetali naturali per chilometro quadrato, con vaste aree di savana e foresta sostituite da piantagioni, pascoli e insediamenti umani.
“Il nostro studio dimostra che il motore principale del declino della biodiversità sul Kilimangiaro è l’espansione umana, non il clima”, afferma Hemp, autore principale e coordinatore del progetto sostenuto dalla Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG). “È un messaggio chiaro: la tutela della biodiversità passa prima di tutto da politiche di gestione sostenibile del territorio”.
Per arrivare a questa conclusione, il team ha integrato dati storici, mappe topografiche del 1911, censimenti della popolazione, immagini satellitari e rilievi sul campo relativi a quasi 3.000 specie vegetali distribuite lungo i diversi ecosistemi del Kilimangiaro. Si tratta della prima analisi a collegare direttamente la densità di popolazione umana con la densità di specie vegetali su scala di 1 km² in una regione tropicale. I ricercatori hanno evidenziato che la densità di popolazione è aumentata da 30 a oltre 430 abitanti per chilometro quadrato in poco più di un secolo, con un impatto diretto sull’espansione delle aree coltivate e urbane.
Il risultato è stato un progressivo isolamento degli habitat naturali, che ha ridotto la varietà ecologica e alterato la regolazione delle acque e del suolo. “Analizzando un secolo di trasformazioni ecologiche, siamo riusciti a separare gli effetti umani da quelli ambientali,” aggiunge Miyazawa, coautore giapponese dello studio. “È sorprendente constatare che il cambiamento climatico, pur avendo effetti documentati sul ghiacciaio e sulle temperature, non ha inciso in modo diretto sulla biodiversità locale”.
Nonostante il quadro allarmante, la ricerca offre anche segnali di speranza. Le aree dove persistono pratiche tradizionali di agroforestazione sostenibile e le zone protette istituite negli ultimi decenni mostrano una maggiore tenuta ecologica e livelli più elevati di biodiversità. “Queste evidenze indicano che conservazione e benessere umano non sono obiettivi in conflitto”, sottolinea Hemp.
“Le comunità locali che gestiscono in modo sostenibile le risorse del territorio possono contribuire attivamente a invertire il trend di perdita di specie”. Gli autori dichiarano l’assenza di conflitti di interesse e invitano a utilizzare i risultati per promuovere politiche di uso del suolo più sostenibili, che tengano conto della relazione diretta tra densità umana e resilienza ecologica. “Il futuro del Kilimanjaro,” conclude Hemp, “dipende da quanto sapremo bilanciare le esigenze di chi vi abita con la protezione della montagna più iconica del continente".

 2 mesi fa
30
2 mesi fa
30
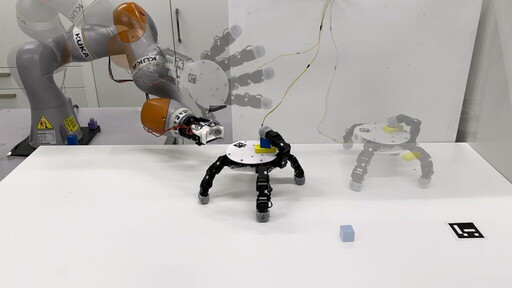





 ·
·
 ·
·
 ·
·
 ·
·
 ·
·
 ·
·
 ·
·
